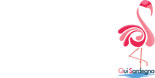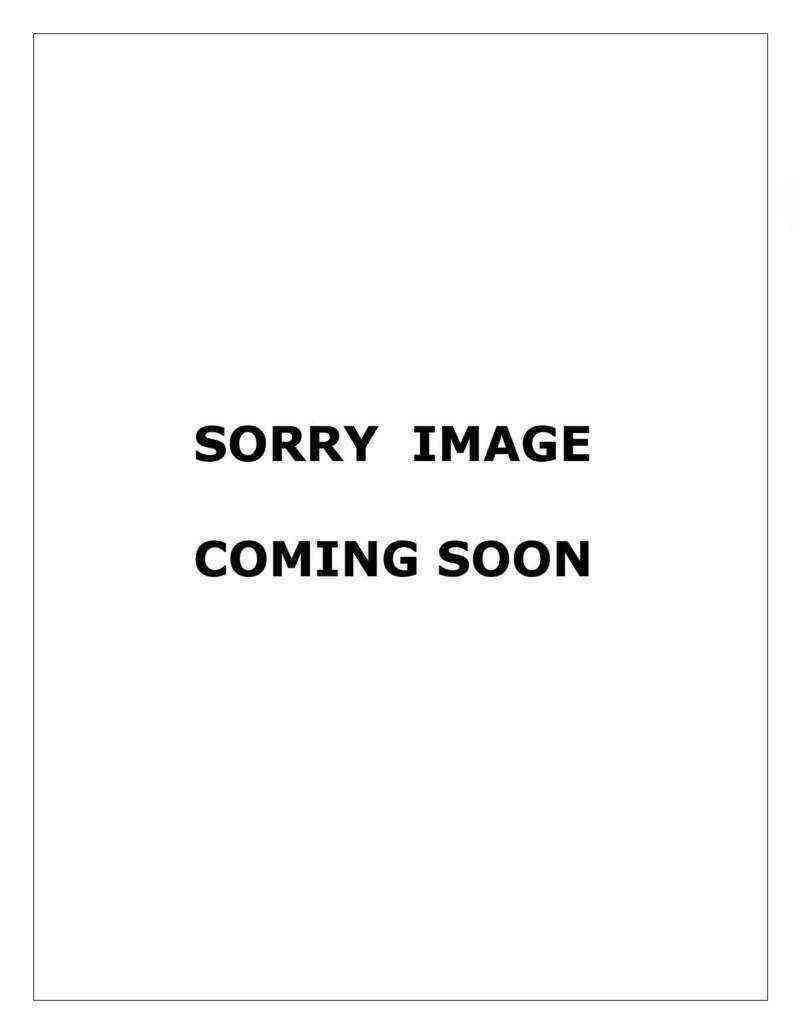La Femmina Accabadora
La femmina accabadora
Con il termine sardo femina accabadora, oppure femina agabbadòra, comunemente accabadora (s'accabadóra, lett. "colei che finisce", deriva dal sardo s'acabbu, "la fine") si soleva indicare una donna che uccideva persone anziane in condizioni di malattia tali da portare i familiari, o la stessa vittima, a richiederne l'eutanasia. Il fenomeno avrebbe riguardato alcune regioni sarde come Marghine, Planargia e Gallura. La pratica non doveva essere retribuita dai parenti dell'anziano poiché il pagare per dare la morte era contrario ai dettami religiosi e della superstizione. Diverse sono le pratiche di uccisione utilizzate dalla femina accabadora: si dice che entrasse nella stanza del morente vestita di nero, con il volto coperto, e che lo uccidesse tramite soffocamento con un cuscino, oppure colpendolo sulla fronte tramite un bastone d'olivo (su mazzolu) o dietro la nuca con un colpo secco, o ancora strangolandolo ponendo il collo tra le sue gambe. Lo strumento più utilizzato, del quale si trovano ancor oggi dei reperti, consisteva in una sorta di martello di legno ottenuto tagliando un ramo dal quale si dirama un ramo secondario più piccolo che tagliato a misura diveniva il manico del martello la cui testa era un moncone del ramo principale: un martello originale di questo tipo è visibile presso il Museo etnografico Galluras di Luras. Non c'è unanimità storica su questa figura: alcuni antropologi ritengono che la femina accabadora non sia mai esistita. Si hanno prove di pratiche della femmina accabadora fino a pochi decenni fa; pare che negli anni venti del '900 vi siano state le ultime due pratiche di una Femmina Accabbadora, precisamente una a Luras(1929), una a Orgosolo (1952) e una a Oristano. Una delle teorie per giustificare questo tipo di pratica è basata sulle difficoltà di spostamento e di sussidio nei tempi passati, per cui nei paesi isolati e molto distanti da qualsiasi ospedale la famiglia di un soggetto anziano non autosufficiente e quindi in bisogno di cure assidue avrebbe avuto numerosi problemi ad assisterlo, dal momento che il lavoro agricolo era l'unica loro possibilità di sussistenza. Alcuni autori non descrivono come strumento principale dell'accabadora una mazza, ma un piccolo giogo in miniatura che veniva poggiato sotto il cuscino del moribondo, al fine di alleviare la sua agonia. Questo si spiega con uno dei motivi principali per cui si credeva che un uomo fosse costretto a subire una lenta e dolorosa agonia in punto di morte: se lo spirito non voleva staccarsi dal corpo era palese la colpa del moribondo, il quale si era macchiato di un crimine vergognoso, aveva bruciato un giogo, o aveva spostato i termini limitari della proprietà altrui, oppure aveva ammazzato un gatto. Altro rito che veniva compiuto era quello di togliere dalla stanza del moribondo tutte le immagini sacre e tutti gli oggetti a lui cari: si credeva in questo modo di rendere più semplice e meno doloroso il distacco dello spirito dal corpo. Secondo le riflessioni dell'Alziator il compito dell'accabbadora non è tanto quello di mettere fine nel senso letterale del termine alle sofferenze dei moribondi con l'utilizzo di uno strumento palesemente inquietante, quanto quello di cercare di accompagnarli alla fine della loro agonia tramite riti di cui si è sicuramente persa la memoria. Tuttavia lo stesso studioso cagliaritano afferma di muoversi nell'alveo della leggenda e non fornisce prove certe dell'esistenza della "femmina". Questo perché molte delle notizie sulle Accabadore sono di fonte ellenica e valeva dunque il concetto che ciò che era ellenico era civilizzato il resto era un mondo barbarico. Inoltre Alziator stesso nei suoi studi si stupisce dell'omertà della chiesa; secondo lui, infatti, se per i parroci era impossibile non sapere di queste pratiche, era altrettanto impossibile che non le denunciassero quantomeno all'autorità ecclesiastica, giacché erano apertamente e pubblicamente contrarie a riti meno violenti e pericolosi, ma altrettanto folkloristici, come quelli riguardanti le prefiche.
Figure simili
Quella della accabadora non è l'unica traccia di forme di eutanasia in Sardegna, difatti alcuni classici latini riportano che in Sardegna gli anziani, raggiunta l'età di 75 anni, venissero portati in prossimità di un alto dirupo e buttati di sotto. La motivazione ancora non è chiara, ma è possibile che il rito fosse un'invenzione degli autori per rispondere al problema della straordinaria longevità dei sardi.[senza fonte] Nel Nuorese il ruolo di accabadora veniva svolto dalle vedove rimaste sole ed in miseria, che venivano mantenute dal vicinato con le elemosine, ancora negli inizi degli anni 60 non era raro vederle passare vestite di nero, a chiedere l'elemosina, e ricompensate con il pane appena fatto. Riferimenti alle pratiche di eutanasia simbolica o attiva si ritrovano anche in altri ambiti del Mediterraneo, in particolare nel Salento. Il celebre autore molfettese Saverio La Sorsa, nato nel 1877, assai stimato dagli antropologi come il Bronzini, nelle sue pubblicazioni sulle tradizioni popolari pugliesi dal 1910 al 1970, ne cita il ricorso, con un preciso riferimento anche a certi paesi isolani: "è stentata l'agonia di chi in vita abbia violato un termine o bruciato un giogo […] per alleviarla è d'uopo mettere sotto il capezzale del morente una pietra o un giogo nuovo, una chiave ovvero una scure. In certi paesi di Sardegna, quando il moribondo tarda ad esalare l'ultimo respiro i parenti avvicinano alla sua testa o al collo un pettine o un giogo per alleviargli le sofferenze.” (Folklore pugliese”, volume secondo, 1988, pagina 238-9). Quello dell'accabadora non era considerato il gesto di un'assassina ma era visto dalla comunità come un gesto amorevole e pietoso di chi aiuta il destino a compiersi. Il suo atto è la fine benevola di una vita diventata troppo sofferente; lei è considerata l'ultima madre.