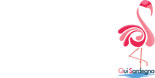Il Castello di San Michele

Situato alla periferia nord della città di Cagliari, rivolto verso la piana del Campidano, si erge il Castello di San Michele che, oltre alla sua importanza storica, è considerato uno dei momumenti più significativi e affascinanti della città. Il castello, costruito tra il X secolo a.C. e il XV secolo a.C. in cima al colle omonimo, sorge nel sito dove in epoca bizantina fu costruita la chiesa di San Michele. Per la sua posizione strategica, ad un'altitudine di 120 metri sopra il livello del mare, fu considerato per secoli una fortezza di avanguardia per la difesa della città. Dal colle infatti si domina per lungo raggio la città sottostante e si ha ampia visione del mare, rendendo cosi più semplice ed efficace il controllo e la difesa delle principali vie d'accesso a Cagliari e alla città di Santa Igia, ovvero la capitale del Giudicato di Cagliari. L’edificio ha forma quadrangolare con tre torri angolari, che in origine erano quattro, raccordate da cortine murarie. È circondato da un fossato, facilmente superabile, scavato nella roccia con un ponte levatoio. Nel lato orientale si ergono due possenti torri quadrate con scarpe a bugnato e sottili feritoie a difesa della porta di ingresso che era munita di saracinesca. Nel lato ovest si riconoscono due ingressi affiancati e quanto rimane della chiesetta altomedievale a due navate, dalla quale il maniero prende il nome. Le origini del Castello di San Michele sono molto antiche, probabilmente il suo primo impianto risale al periodo bizantino o primo giudicale, X secolo, e fu edificato con funzione difensiva. Nel 1089 fu donato dal giudice Torchitorio I ai monaci di San Vittore di Marsiglia che controllavano, oltre a numerose chiese e conventi nel giudicato di Cagliari, il commercio del sale. Nei decenni successivi con ogni probabilità i monaci vi svilupparono un centro monastico. Caduto il giudicato nel 1258, Cagliari e il suo territorio furono amministrate direttamente da Pisa e il complesso fu smantellato per cui il sito sembrò destinato a cadere nell’oblio. In seguito, conclusa la prima fase della conquista aragonese, nel 1324, quel che rimaneva del castello fu incluso nel feudo concesso dall’infante Alfonso d’Aragona al cognato Berengario I, nobile signore valenzano, che negli anni successivi fece costruire, ex novo e a sue spese, il castello inglobando entro le possenti cortine che ancora oggi ammiriamo, i resti dell’antico complesso monastico per poi farne, con il tempo, la sede della propria residenza. Successivamente alla caduta del Giudicato d’Arborea, la funzione difensiva diventò secondaria. Fu allora, nel periodo in cui era feudatario il conte Giacomo Carroz, che il castello diventò una delle più lussuose residenze della Sardegna. Dopo la morte di Berengario I nel 1336 il castello, nonostante i numerosi tentativi effettuati dalla chiesa di rivendicarne la proprietà, restò per lungo tempo proprietà dei Carroz. Elegantemente ammobiliato e arredato, il castello ospitava un centinaio di persone fra armigeri e servitori, e Berengario II, figlio del primo Berengario, ne fece la sede della propria residenza. Scoppiate le guerre tra Aragona e Arborea, a partire dal 1353, l’edificio assunse un’importanza strategica fondamentale per la difesa della città dagli attacchi delle truppe del giudice d’Arborea. Nel 1369, a seguito dell'invasione del sud dell'isola da parte di Mariano IV d'Arborea, il re Aragonese finanziò gli approviggionamenti della fortezza, con l'ordine che fosse difeso da un'adeguata guarnigione. Nel 1381, nel tentativo di impadronirsi di Cagliari, le truppe arborensi assediano il castello ma senza risultato e, nel 1383, il re conferma ancora una volta la fortezza ai Carroz. Nel 1469 un esplosione causa un grosso incendio, con la conseguente morte del conte Giacomo Carroz e la successiva breve occupazione del maniero, nel 1470, da parte del marchese Leonardo Alagon. Nel 1511, con la morte di Violante Carroz, figlia di Berengario e ultima esponente della famiglia Carroz, il castello venne ereditato da Guglielmo De Centelles, nipote di Violante Carroz, che lo concede al Demanio statale incamerandolo tra i beni della Corona spagnola, al quale rimase fino all'unità d'Italia. Nel corso dei secoli successivi l’amministrazione reale lo trascurò e lo utilizzò per far fronte a varie necessità e quando, nel 1637, i Francesi minacciarono la Sardegna durante la guerra dei Trent’anni, la fortezza fu dotata di alcuni pezzi di artiglieria. Il periodo tra il XV e il XVI secolo rappresenta il momento di maggiore decadenza per il castello che proprio in quel tempo fu abbandonato. Nel 1625 la destinazione d'uso del castello cambierà ancora una volta divenendo lazzaretto e luogo di quarantena durante la "peste di Sant' Efisio". Nel corso del 1700, prima con gli austriaci e poi con i Savoia, il castello iniziò una nuova fase di decadenza. La sorte di san Michele non cambiò dopo il 1720, quando la Sardegna passò ai Savoia. Nel 1773 fu utilizzato come ospedale per militari invalidi, nel 1793 fu attrezzato per la difesa contro la minaccia di sbarco dei Francesi e nel 1820 fu sede di militari invalidi. Nel 1861 Cagliari cessò di essere una piazzaforte e il castello perse ogni interesse militare. Alla fine del 1800, incaricato dal Marchese Roberto di San Tommaso, che lo acquistò nel 1868, il Castello di San Michele venne restaurato dall'architetto Dionigi Scano. Tra il 1930 e il 1977 San Michele divenne sede della stazione radio gestita dalla Marina Militare italiana e, dopo un periodo di abbandono, è stato restaurato, tra il 1988 ed il 1995, grazie all’intervento dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, della Soprintendenza ai Beni Ambientale e Artistici e della Soprintendenza Archeologica. Dal 2001 l'interno del castello ospita numerose iniziative culturali come mostre, conferenze e diverse manifestazioni artistiche.
Wikimedia
Di Chris - CC BY-SA 3.0
27/08/2014